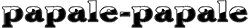Cinema
Dentro le altezze
della bellezza
di Margherita Lamesta
Il Grande Gatsby e la Grande bellezza come in uno specchio

Il grande Gatsby di Baz Luhrmann ha aperto la 66esima edizione del Festival di Cannes, mentre La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, ne ha letteralmente conquistato la critica…ma la pensano così proprio tutti?
Il nostro giornale si è occupato di entrambi gli eventi cinematografici tuttavia ora –trascorso il tempo necessario per la “sedimentazione” che alcune opere dell’ingegno richiedono - proviamo ad affrontare i labirinti dei due film, in un gioco analitico che li metta a confronto.
Personalmente sono stata conquistata più dalla pellicola di Baz Luhrmann, che dal Nostro Sorrentino, di cui tutti abbiamo amato e apprezzato il suo This must be the place, ad esempio, nel quale la grande prova d’attore, offerta agli spettatori dal genio e dal talento di Sean Penn, ha avuto ragione sul pubblico, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal regista. Ciononostante, questa “grande bellezza”, nell’omonima pellicola, per quanto mi sforzi non riesco ad individuarla pienamente, se non in una chiave ironica che voglia presentare il contrario della bellezza, tanto più se grande. È possibile, comunque, che Sorrentino abbia voluto ricercare la grande bellezza dell’uomo e del mondo, quella segreta e chiusa con una chiave difficile da trovare. Probabilmente, il regista ha voluto offrire al suo pubblico un pamphlet di situazioni, che portassero a cercare dentro di noi la difficile chiave di cui sopra, per aprire il segretissimo scrigno, custode proprio di quella grande bellezza presente nella parte più profonda di ognuno di noi. Come dire…le intenzioni sono delle migliori ma la strada intrapresa non è sempre convincente. Il punto è che Sorrentino ha scelto qualcosa dalla fattura piuttosto anacronistica agli occhi di oggi, verrebbe da pensare. Non si può rinverdire il mito di Fellini. Il maestro consegnava alla storia un’analisi amara, dentro i toni appositamente lascivi, di una Roma che si avviava verso una delle più grandi evoluzioni culturali della storia, con i relativi rovesciamenti semantici epocali, in tutte le arti.

Che Toni Servillo sia uno dei più grandi talenti di Casa Nostra, di cui tutt’Italia deve essere fiera, compresi i non cinefili, è un assioma indiscutibile e l’attore napoletano non delude mai le aspettative. Quel che stride, invece, è il suo utilizzo, a mio avviso forzato, da parte del regista, per un ruolo che vuole evidentemente rifarsi al Mastroianni de La dolce vita. Servillo, sia pur bravissimo come interprete di un dandy, non ne ha le physique du role né è credibile come personaggio lascivo, in preda ad un unico ricordo puro – la sua prima volta – rinfrescato dalla spontaneità (anche eccessiva) del personaggio interpretato da Sabrina Ferilli, così autentico da fornirgli il “la”, per un nuova iniziazione all’arte dello scrivere. Un romanzo pubblicato a 17 anni, premiato con il “Bancarella”, e la possibilità di un nuovo romanzo, magari di successo, a differenza del primo, è alquanto inverosimile, se frutto della penna di un attore-personaggio in piena terza età. Si possono tirare le somme della vita, allorquando si è attraversati da un bisogno di responsabilità ma per poter voltare pagina, farlo davvero, bisogna essere “nel mezzo del cammin di nostra vita” e non a tre quarti del suo percorso.
L’atmosfera chiaramente almodovariana, in cui Sorrentino immerge la bella Roma, se da una parte lancia il messaggio che “non è mai oro tutto ciò che luccica”, d’altro canto, addolora anche chi romano non è. Il Colosseo o San Pietro sono di per sé una “grande bellezza”, e tali rimangono, anche se gli uomini che stanno loro intorno si sono – ahi loro - assuefatti a queste bellezze immense.
Sorrentino, con alle spalle poco più di 40 anni di vita, si dimostra certamente acuto nel restituire una dimensione sentimentale ed individuale, attraverso una straordinaria ampiezza di visione ma non riesce a centrare l’obiettivo pienamente, se in gioco ci sono i macro-temi sociali, politici e culturali. La Roma di Sorrentino è come una diva morta e indifferente, di fronte alla vacuità esistenziale di Jep Gambardella-Toni Servillo e i suoi, laddove la Roma di Fellini era ugualmente silente ma di un silenzio, che nascondeva sotto la cenere il grido sociale e politico, che si sarebbe levato di lì a poco.


Oggi la disgregazione è davvero totale e non ci sono, purtroppo, elementi autentici e consolidati, che preludano ad un cambiamento epocale. Mentre l’amaro pessimismo del Maestro - che separa la ragazza dal giornalista fortemente disincantato, alla fine del film, il quale si conclude con l’occhio cristallizzato di una manta morta - è una lucida e fredda anticipazione degli eventi, Sorrentino trova, alla fine del film, un afflato inspiegabile ai nostri occhi e, soprattutto, lo fa per bocca di un sessantacinquenne, sia pur splendidamente interpretato. Almodovar e Fellini, che il Nostro ricorda, offrono personaggi profondamente stagliati e sfaccettati nella psicologia, con toni tanto grotteschi nel primo, quanto raffinati nel secondo. Entrambi, tuttavia, fanno un’analisi profonda della loro società e gettano uno sguardo amaro, con risvolti speculativi, a cui potremmo associare anche la poetica di un Woody Allen.
L’opera del regista napoletano, invece, sia pur complessa e stratificata, nel suo inseguire lo stupore, giocando tra ascesa e caduta, come in sospeso tra i due piani, attraversa suggestioni puramente estetiche ma sceglie un linguaggio dirompente, non sempre efficace ed elegante. Complessa e stratificata, la pellicola insegue lo stupore sublime e il terreno disincanto; eppure nell’equilibrio e nel fascino della sospensione, tra i due piani altalenanti, essa trova il culmine in geometrie estetiche non sempre armonizzate con la sceneggiatura (il paragone tra il brodino e la scopata non è del tutto felice), perché nessuno dei tanti argomenti toccati ottiene un adeguato approfondimento. È qui la cruciale differenza tra Fellini, Almodovar e Sorrentino.


Neppure il film di Luhrmann approfondisce davvero Gatsby ma nel romanzo di Fitzgerald - come rileva lo stesso Di Caprio – “l’autore ha lasciato tanti spazi che si chiede a chi legge di riempire”, oppure a chi si assume il compito di tradurre il romanzo in pellicola, aggiungeremmo. Ognuno ha la sua verità, la sua interpretazione e il regista di Moulin Rouge ci dà la propria. A sua difesa, dunque, c’è l’immaginazione fervida di cui è fatto il personaggio stesso. Gatsby è lui stesso Il sogno, nella misura in cui s’identifica perfettamente con il suo sogno, il quale sarà l’unica vera sua essenza: impossibile da circoscrivere o definire chiaramente, il sogno risulta sfuggente e fuggevole, per natura stessa. In più, quello di Gatsby è un sogno reale, e in quanto tale incorruttibile, in netta antitesi con la sua realtà fatta di corruzione all’ennesima potenza, di menzogna lucida e finemente premeditata.
“Il film”, come il romanzo - continua Di Caprio – “più che una storia d'amore racconta la tragedia del nuovo americano, che nel nuovo mondo, quello in cui tutto è possibile”, cerca di diventare l’Innominato più potente ma “perde il senso della sua ricerca”. E in questo la pellicola è attuale, mentre quella di Sorrentino risulta un po’datata, benché resti apprezzabile la luce che il regista de Il Divo getta sui nostri giorni, sul come scorrano e sul dove essi stiano correndo. Manca, però, un’intuizione originale sul futuro e/o una premonizione sullo stesso. Insomma, una grande bruttezza ci attanaglia, perché si è totalmente perduto il senso della bellezza; questo è un chiaro messaggio d’avvertimento ma il regista non scava davvero a fondo, preferendo dipingere degli affreschi, che spetta allo spettatore vivificare, lasciando a lui anche la libertà di scelta fra le tante situazioni presentate.
Il tripudio di colori, con danze vistose e pacchiane, che condisce entrambe le pellicole, inoltre, mentre in Sorrentino risente di una lunga e riconoscibile influenza spagnola – Almodovar docet – nel film statunitense dimostra un’identità tutta americana – si pensi al magnifico Moulin Rouge dello stesso regista o a Chicago di Marshall. In America, infatti, è la formazione accademica stessa che porta a un livello altissimo quelle capacità. Meglio sarebbe stato, probabilmente, per Sorrentino, ambientare La Grande Bellezza a Napoli, sua Terra d’origine, dove noi italiani possiamo vantare una tradizione, e quindi un’identità, nella danza e nel canto, dal respiro plurisecolare ed universale.
Nell’opera di Lehrmann, invece, l’amara espressione del cinismo, che s’insedia senza pietà in chi ha avuto tutto dalla vita e dagli altri, è come una radiografia che nel film colpisce senza esclusione di colpi e penetra davvero a fondo. Gatsby s’identifica pienamente con il suo sogno d’amore, per esso è diventato chi è diventato; eppure morirà solo, perché la macchia di chi viene su dal niente non è sanabile né con i soldi né con la purezza di un amore, emblema stesso dell’amore per antonomasia, nel giovane businessman. Attaccato ad un’idea fino alla fine, Jay riceve dal suo (s)fortunato destino almeno l’ultima illusione: la telefonata dall’amata Daisy, ma lo spettatore sa perfettamente che è Nick che lo sta chiamando. Daisy lo ama come può, non a costo di tutto, perché non è in grado di amare nessuno a costo di tutto. Certe pennellate rosse, a colpi di unghie e di ferite profondissime, nella vita sono riservate solo a chi mette in gioco tutto, ma proprio tutto, per il suo ideale, anche se esso resterà solo ed esclusivamente un ideale. Un uomo che è convinto di cambiare il suo passato, quale è Gatsby, non può non conquistare l’approvazione degli spettatori. Tutti vorremmo cambiare qualcosa del nostro passato ma possiamo solo qualcosa – e a volte ben poco - sul nostro futuro. Nick-Toby Maguire avverte Jay su questo ma l’occhio di Fitzgerald, che a sua volta s’identifica con quello di Nick e di Lehrmann al tempo stesso, non può nulla contro una fervida immaginazione ed una ossessiva convinzione, nate oltretutto dalla sua penna. Eppure va bene così! Perché bisogna per forza portare alla realtà qualcosa o qualcuno non nato per questo? I sogni aiutano a vivere anche coloro che non hanno il coraggio di sognare, perciò sono socialmente indispensabili.


Va aggiunto comunque, che mentre Di Caprio è bravo quanto Servillo nella traduzione del suo personaggio, il primo ha una marcia in più rispetto al secondo, perché aiutato da una fisicità perfettamente in linea con il suo ruolo, a differenza di Servillo che ha dovuto pagare lo scotto di un personaggio non proprio adatto a lui. Del resto, però, il cast dell’opera italiana è tutto di livello: si pensi al disadattato interpretato magistralmente da Verdone o al bellissimo battibecco tra Servillo e Galatea Ranzi, e ancora all’alto prelato di Roberto Herlitzka. Di Caprio, invece, non è affiancato da talenti del suo stesso spessore. Daisy, col volto di Carey Mulligan, non ci offre il livello di fascino e conturbanza richiesto dal ruolo, proprio lei che invece si è fatta ammirare in Shame, dove ci ha regalato sfumature di fragilità, perfettamente in linea con il personaggio di Steve McQueen. Molto più in parte sarebbe stata Elizabeth Debicki - che nel film interpreta l’algida Jordan - perché aiutata anche da un viso ben più in sintonia con l’era del Charleston, a differenza della smaccata modernità ravvisabile nei tratti della Mulligan. Eppure, Di Caprio sostiene il film magistralmente e ci regala tutte le sfumature che tengono in piedi un sogno, incluse quelle appena accennate o del tutto sottese.
Dunque, mettere queste opere allo specchio fa venir voglia di modificare i titoli, accorpandoli entrambi per indicare il film di Baz Luhrmann - La Grande Bellezza del grande Gatsby, per esempio - e cambiando quello di Sorrentino in La dolce vita del nuovo millennio. Ciò, pur riconoscendo la strada spianata dal regista napoletano verso un’analisi personale, che spetta ad ognuno di noi, sul dove stiamo andando e sul cosa possiamo fare per salvarci dal baratro, liberando e custodendo la preziosa bellezza, rinchiusa dentro il nostro profondo più segreto.